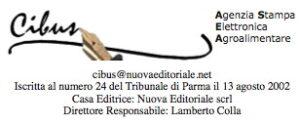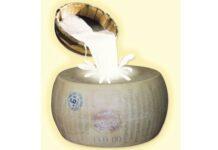L’atto sanzionatorio, lungi dall’essere una mera ritorsione politica, costituisce un gesto che travolge i confini tra fatto e diritto, tra potere e norma, rendendo manifesta una patologia di sistema: l’inversione della subordinazione del potere alla legge, sostituita dalla sovranità autopoietica di chi, potendo impunemente sanzionare l’istanza critica, si arroga il diritto di sospendere la normatività stessa in nome della sua forza. In tale gesto si consuma un attentato alla “ratio formalis” del diritto internazionale, il quale, nel suo fondamento teoretico, si regge su una concezione della normatività come limite reciproco tra entità sovrane, non come proiezione extraterritoriale della volontà egemone.
La figura del relatore speciale dell’ONU non è riducibile a portavoce politico, ma si radica nell’ontologia giuridica dell’”officium veritatis”: egli incarna la funzione testimoniale e giudicante della ragione giuridica, che, in quanto tale, non può essere legittimamente soppressa dalla reazione del soggetto indagato.
Sanzionare Albanese per l’esercizio del suo mandato equivale a negare l’”auctoritas rationis”, principio primo dell’ordine normativo internazionale. L’azione statunitense è, in questo senso, un rigetto della “veritas iuris”, ossia di quel fondamento per cui il diritto vale non in quanto voluto, ma in quanto giusto, non in quanto prodotto del potere, ma in quanto misura del potere.
La filosofia del diritto, soprattutto nella sua matrice classica giusnaturalistica, insegna che “lex est ordinatio rationis ad bonum commune ab eo qui curam communitatis habet promulgata” (così Tommaso d’Aquino).
Nulla, in questo orizzonte, può essere detto “diritto” se non è conforme alla ragione e orientato al bene comune. Tuttavia, proprio questa definizione viene sovvertita quando il diritto è usato come arma per colpire chi ha osato denunciare l’ingiustizia, invertendo l’ordine gerarchico tra norma e potere: la sanzione diviene lo strumento con cui la forza silenzia la ragione, la politica reprime il giudizio, la volontà prevale sulla verità.
L’anomia che ne scaturisce è mascherata da legalità, ma in essa si consuma la trasformazione del diritto da criterio della giustizia in strumento di dominio. Il punto nodale non è se l’analisi della relatrice speciale fosse o meno condivisibile: ciò che importa è che essa era giuridicamente fondata, sostenuta da norme cogenti del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani, tra cui la IV Convenzione di Ginevra del 1949 e la Convenzione contro il genocidio del 1948. Colpire la relatrice equivale a rendere non dicibile la verità giuridica ogniqualvolta essa confligge con l’interesse del più forte. È l’affermazione implicita che esiste una “lex lata” per i deboli e una “lex voluntatis” per i forti, che il giudizio giuridico è legittimo solo se non tocca l’intangibilità del potere. In tal modo si determina la dissoluzione di quella “communitas iuris” che costituisce la precondizione del diritto internazionale, ossia un ordine nel quale il primcipio consuetudinario “pacta sunt servanda” non è subordinato alla gerarchia della forza. L’atto statunitense, allora, non è solo una violazione procedurale: è un gesto teoretico, perché modifica l’ontologia del diritto internazionale stesso, riducendolo da sistema ordinativo a strumento operativo. Se i relatori ONU, garanti della normatività critica, possono essere colpiti quando esercitano la loro funzione, allora il diritto internazionale cessa di essere spazio di responsabilità comune e diventa campo di esercizio della volontà (purtroppo lo è già da tempo).
La “lex talionis”, rigettata in nome del progresso giuridico, rientra così dalla finestra nella forma dell’unilateralismo sanzionatorio. In questa dinamica, il concetto stesso di responsabilità universale viene tradito. La denuncia di Francesca Albanese circa la “economia del genocidio” non è invenzione ideologica, ma rilettura giuridica di una prassi di sostegno materiale e tecnologico a un’azione militare che, secondo i parametri giuridici definiti dallo Statuto di Roma, potrebbe (il condizionale è d’obbligo) configurare crimini internazionali.
Negare legittimità a tale lettura significa proclamare l’irresponsabilità di interi apparati statali e imprenditoriali, significa sospendere la validità del diritto penale internazionale per alcuni, mentre la si impone ad altri.
La diseguaglianza ontologica dei soggetti internazionali, che il diritto postbellico si era proposto di superare, viene così nuovamente consacrata. L’azione statunitense è allora espressione perfetta di ciò che Carl Schmitt (1888-1985) definiva decisionismo sovrano: la facoltà di sospendere la validità della norma per salvaguardare l’integrità della propria decisione. Ora, proprio in ciò consiste la negazione dell’ordine giuridico. Dove il potere decide chi può essere giudicato e chi no, dove il diritto è subordinato alla convenienza politica, là il diritto è già morto. È stato ucciso dal diritto stesso, usato come maschera della forza. Non è una deriva episodica, bensì una crisi strutturale del diritto come sistema razionale fondato sulla giustizia. Il caso Francesca Albanese, in tal senso, assume il valore paradigmatico di una sfida epocale: la sopravvivenza del diritto internazionale come ordine fondato sul primato della verità giuridica e della giustizia sostanziale. In essa si gioca la possibilità stessa di un mondo retto dalla legge e non dalla forza.
La difesa della relatrice non è difesa individuale, ma salvaguardia dell’essenza stessa del diritto. Tacere, giustificare, relativizzare, significa accettare che la giustizia è funzione della potenza e che la norma vale solo se non disturba l’ordine delle cose. Ovviamente un tale silenzio non è neutrale: è già una forma di partecipazione alla negazione della giustizia. In tutto questo dalle istituzioni italiane neppure una parola!!!
(*) Autore
Daniele Trabucco
Professore strutturato in Diritto Costituzionale e Diritto Pubblico Comparato presso la SSML/Istituto di grado universitario “san Domenico” di Roma. Dottore di Ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico.
Sito web personale
Foto copertina Francesca Albanese autore Esquerda.net